|
 Il 23 maggio del 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria schierandosi a fianco dell’Intesa. Questo primo gigantesco conflitto non solo causa la morte di oltre dieci milioni di persone e la caduta degli imperi centrali, ridisegnando così la geografia dell'Europa, ma si rivelerà alla storia come un evento ancor più funesto poiché getterà il seme per la nascita delle dittature nazi-fasciste che a loro volta saranno responsabili di un ancor più luttuoso e distruttivo conflitto mondiale. Il 23 maggio del 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria schierandosi a fianco dell’Intesa. Questo primo gigantesco conflitto non solo causa la morte di oltre dieci milioni di persone e la caduta degli imperi centrali, ridisegnando così la geografia dell'Europa, ma si rivelerà alla storia come un evento ancor più funesto poiché getterà il seme per la nascita delle dittature nazi-fasciste che a loro volta saranno responsabili di un ancor più luttuoso e distruttivo conflitto mondiale.
Nell’immediato suo dopo guerra, coloro che avevano combattuto nelle trincee, memori degli orrori e delle stragi vissute, annunciarono al mondo che non avrebbero acconsentito che si verificasse un’altra tragedia simile. La Grande Guerra sarebbe rimasta nella memoria dell’umanità come un atto di barbarie che non doveva mai più ripetersi.
Ma quel conflitto, che coinvolse mezzo mondo, non si era generato certo da cause imponderabili come ipotizzato da alcuni storici. Il secolo della nuova modernità sorgeva già sotto un cielo denso di nubi minacciose, foriere di eventi sinistri che giungeranno al suo apogeo dopo essere passate attraverso le due Guerre dei Balcani.
Visitando i cimiteri di Serbia, Grecia, Bulgaria e Albania, sulle lapidi dei soldati si legge: caduti sul campo dell’onore. Uomini sacrificati inunasuccessione di eventi che la storiografia europea solitamente tiene separati dalle guerre balcaniche del 1912-1913.
Questi conflitti così localizzati non sarebbe esatto considerarli esclusivamente espressione dello scontro degli imperialismi europei; le guerre balcaniche furono piuttosto facilitate e incoraggiate dai forti antagonismi delle potenze, più precisamente dalle rivalità fra la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa.
La crisi provocata nel 1908 dall’annessione della Bosnia Erzegovina da parte dell’Austria-Ungheria, aveva messo fine al quel tacito accordo di non aggressione che dal 1886/7 era in atto tra San Pietroburgo e Vienna.
Isvolski, ministro degli esteri dello zar, e il suo successore Sazanov non dimenticarono l’affronto di quella proditoria annessione, tanto più che colpiva la Russia, già umiliata dalla disfatta da parte del Giappone e indebolita dai moti rivoluzionari del 1905.
Le controversie balcaniche fornivano dunque all’impero degli zar possibilità di rivincita senza che si rendesse necessario affrontare le Potenze della Triplice Alleanza. E’ proprio sotto l’egida di San Pietroburgo che gli stati balcanici tentarono dapprima timidi avvicinamenti, poi alleanze, per giungere infine a una spartizione dell’eredità ottomana in Europa.
 La rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908 era sfociata in una crisi di intolleranza nazionalistica che risvegliò tutti gli altri nazionalismi. Il Comitato dell'Unione e Progresso turco si presentava come una forza di rinnovamento del vecchio impero ottomano e questo mise fortemente in allarme le Potenze europee. Infatti, lo stesso anno, davanti alla Duma, il ministro russo Isvolski ventilò la costituzione di un blocco balcanico. La rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908 era sfociata in una crisi di intolleranza nazionalistica che risvegliò tutti gli altri nazionalismi. Il Comitato dell'Unione e Progresso turco si presentava come una forza di rinnovamento del vecchio impero ottomano e questo mise fortemente in allarme le Potenze europee. Infatti, lo stesso anno, davanti alla Duma, il ministro russo Isvolski ventilò la costituzione di un blocco balcanico.
I Serbi e i Bulgari procedettero a reciproci sondaggi mentre la guerra italo - turca incoraggiò tutti gli altri potenziali eredi a dividersi ciò che del territorio balcanico restava ancora sotto il dominio della Porta. Nel 1912 tutti questi piani segreti giunsero a concretizzarsi.
Tra Belgrado e Sofia le discussioni furono lunghe e difficili e si conclusero, nel marzo 1912, con un’alleanza militare difensiva nel caso di aggressione da parte dell’Austria-Ungheria o della Turchia tuttavia, in un documento segreto, si precisavano le modalità di una spartizione della Macedonia e delle regioni vicine. Il Kossovo e la regione di Novi Pazar, sarebbero tornate alla Serbia mentre i territori ad est del Rodope e la vallata della Struma sarebbero state date alla Bulgaria.
Due mesi dopo era Atene che siglava un analogo accordo con Sofia, nettamente in chiave antiottomana ma senza alcun cenno a clausole territoriali, aspirando ambedue al possesso di Tessalonica. In ottobre, il Montenegro firmava con Serbia e Bulgaria accordi di intervento militare in caso di ostilità con Istanbul.
L’insieme di questi atti diplomatici viene definito come la Seconda Lega Balcanica, con un richiamo alla prima degli anni 1865-68, soffocata sul nascere dall’assassinio a Belgrado del principe Mihailo.
Naturalmente Istanbul, così come le altre capitali europee, era al corrente del contenuto sostanziale di queste trame, ma era paralizzata da sommovimenti nella sua politica interna e dalla crisi dell’esercito, esposto agli attacchi italiani in Libia e all’insurrezione albanese.
Quanto alle Potenze Occidentali, esse erano profondamente divise sulla possibilità di un’esplosione nazionalistica che, a ragione, definivano la polveriera balcanica, mentre Russia e Imperi Centrali incoraggiavano gli stati slavi anziché frenarli.
Pur tuttavia gli stati balcanici decisero in totale autonomia.
Il 30 settembre 1912 si mobilitarono e richiesero, con un ultimatum, importanti riforme amministrative in Macedonia. Non avendo Istanbul dato alcun cenno di risposta, l’8 ottobre il Montenegro invase l’Albania del nord. La settimana seguente la Porta, dopo aver invitato gli ambasciatori di Serbia e Bulgaria a lasciare le loro sedi, il 18 ottobre dichiarava lo stato di  guerra. Contestualmente la Grecia, in nome dell’Enosis di Creta, si univa agli alleati. Le grandi Potenze inviarono sul campo i loro esperti per osservare le manovre dal vivo con la convinzione di una rapida vittoria delle forze turche, armate con i nuovissimi fucili Mauser e con i cannoni Krupp, e organizzate dai generali tedeschi von Molke e von Goltz. Ma gli eserciti della coalizione balcanica disponevano di un numero maggiore di uomini, giacché la Porta doveva sorvegliare sul Caucaso le frontiere con la Russia nonchè le popolazioni arabe da tempo in agitazione. Inoltre i soldati cristiani, che si battevano per obiettivi nazionalistici, si rivelarono combattenti migliori, più mobili e determinati. La campagna dei bulgari fu la più brillante. Le principali forze ottomane si erano concentrate in Tracia quindi Ferdinando I, re di Bulgaria, lanciò su di esse i suoi eserciti, che strinsero d’assedio Edirne e, vittoriosi a Lüleburgaz e a Buna Hissar, furono fermati solo dalle linee fortificate di Catalca, a soli cinquanta chilometri da Istanbul. Una seconda offensiva in direzione del mar Egeo li portò fino alla Struma e un loro battaglione entrò in Tessalonica, ma questo accadde ventiquattrore dopo le truppe Greche. Infatti l’esercito di re Giorgio, provenendo da sud, aveva occupato Prevenza, sul golfo di Arta, impossessandosi di Tessalonica già l’8 novembre. guerra. Contestualmente la Grecia, in nome dell’Enosis di Creta, si univa agli alleati. Le grandi Potenze inviarono sul campo i loro esperti per osservare le manovre dal vivo con la convinzione di una rapida vittoria delle forze turche, armate con i nuovissimi fucili Mauser e con i cannoni Krupp, e organizzate dai generali tedeschi von Molke e von Goltz. Ma gli eserciti della coalizione balcanica disponevano di un numero maggiore di uomini, giacché la Porta doveva sorvegliare sul Caucaso le frontiere con la Russia nonchè le popolazioni arabe da tempo in agitazione. Inoltre i soldati cristiani, che si battevano per obiettivi nazionalistici, si rivelarono combattenti migliori, più mobili e determinati. La campagna dei bulgari fu la più brillante. Le principali forze ottomane si erano concentrate in Tracia quindi Ferdinando I, re di Bulgaria, lanciò su di esse i suoi eserciti, che strinsero d’assedio Edirne e, vittoriosi a Lüleburgaz e a Buna Hissar, furono fermati solo dalle linee fortificate di Catalca, a soli cinquanta chilometri da Istanbul. Una seconda offensiva in direzione del mar Egeo li portò fino alla Struma e un loro battaglione entrò in Tessalonica, ma questo accadde ventiquattrore dopo le truppe Greche. Infatti l’esercito di re Giorgio, provenendo da sud, aveva occupato Prevenza, sul golfo di Arta, impossessandosi di Tessalonica già l’8 novembre.
Il nuovo Gran Visir Kâmil Pacha, ritenuto un anglofilo, si rivolse a Londra per chiedere una mediazione e ottenne la firma di un armistizio turco-bulgaro sulla linea di Catalca e una riunione nella capitale britannica di tutti i belligeranti. Ma le richieste degli stati cristiani furono tali che l’accordo non si realizzò. I patrioti turchi si sollevarono e il 23 gennaio un gruppo di ufficiali, guidati da Enver Pacha, armi in pugno, cacciò il governo e diede il potere a Shevkt Pacha, capo dell’armata. A Londra le trattative si interruppero.
Le operazioni sul campo ripresero all’inizio di febbraio. La resistenza ottomana si era organizzata e i combattimenti si fecero aspri, tuttavia gli eserciti della coalizione balcanica, superiori per numero, fecero cadere le piazzeforti ottomane una dopo l’altra.
Il 6 marzo i greci en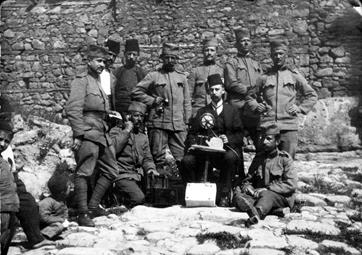 trarono in Jannina, il 28, dopo la cruenta battaglia di Bulai, i bulgari del generale Ivanov, dopo un assedio di cinque mesi, si impadronirono di Edirne ed infine, il nove aprile, i montenegrini entravano a Scutari. trarono in Jannina, il 28, dopo la cruenta battaglia di Bulai, i bulgari del generale Ivanov, dopo un assedio di cinque mesi, si impadronirono di Edirne ed infine, il nove aprile, i montenegrini entravano a Scutari.
La conferenza di Londra, 30 maggio 1913, imponeva agli ottomani l’abbandono di tutti i territori a occidente della linea che va da Midye, sul mar Nero, a Eniz sull’Egeo. Istanbul perdeva anche Creta che andava alla Grecia. Alle Potenze europee veniva assegnato il compito di regolare lo statuto delle zone albanesi e delle isole Egee. Shevket Pacha, patriota dell’Unione e Progresso, pagò con la vita la paternità di quella sconfitta: l’11 di giugno veniva assassinato per strada, mentre preparava un colpo di stato. Ma gli unionisti, con un colpo di mano, misero fuori legge i patrioti dell’opposizione ed istaurarono la dittatura. Gli alleati balcanici dovevano ora dividersi le spoglie. Gli accordi, forse non del tutto chiari, apparvero insufficienti ai Bulgari che reclamavano maggiori riconoscimenti territoriali in Macedonia. I Serbi, sperando di annettersi parte dell’Albania, si sentivano frustrati dalla nascita di un principato albanese indipendente ed esigevano compensazioni per aver rinunciato ad una parte di Macedonia. Tessalonica era invece disputata tra bulgari e greci.
Ad inasprire ancor di più il clima di tensione, esploso dal generale malcontento, furono le posizioni assunte dalla Russia e dall’Austria-Ungheria. La prima faceva di tutto per tenere in vita la coalizione, mentre la seconda operava per una sua dissoluzione. La situazione si guastò quando Grecia e Serbia si accordarono per fissare il loro confine sul Vardar e, nel caso in cui Sofia avesse opposto un rifiuto, per intraprendere un’azione armata contro la Bulgaria. San Pietroburgo, informata di queste trattative con un telegramma, intimò ad Atene e Belgrado di sottoporsi all’arbitraggio dello zar. Ma lo Stato Maggiore bulgaro temeva che il tempo giocasse a suo sfavore ed inoltre l’opinione pubblica si stava infiammando sempre di più a causa della Macedonia.
Nella notte fra il 29 e il 30 maggio 1913 Ferdinando I ordinò alle sue truppe di respingere le linee greche e serbe. Belgrado e Atene risposero con una dichiarazione di guerra e si scatenò il secondo conflitto balcanico.
Questa violazione della pace da parte dei bulgari rimane alquanto controversa poiché non è chiaro se quello di Ferdinando I sia stato un proditorio attacco o solamente una manifestazione di forza come reazione all’accordo serbo-greco. Resta il fatto che la Bulgaria si ritrovò isolata di fronte agli antichi alleati mentre, cedendo alle pressioni dell’opinione pubblica, il governo di Istanbul faceva avanzare il suo esercito e il 22 luglio Enver Pascha riprendeva Edirne, città simbolo, essendo stata la prima capitale dell’Impero Ottomano. Ovunque le truppe di Ferdinando dovettero indietreggiare e non furono in grado di fermare i rumeni che, senza alcuna dichiarazione di guerra, avevano occupato la Dobrugia e marciavano su Sofia. Così il 31 luglio la Bulgaria chiedeva l’armistizio. La pace fu firmata il 10 Agosto a Bucarest e per i Bulgari fu una pace dura poiché perdettero Edirne e Kirklareli, mantenendo tuttavia uno sbocco in Egeo sul golfo di Kavala.
Queste guerre non solo furono disastrose per tutti gli stati della penisola, ormai divisi da accuse reciproche di atrocità e da odi che durarono fino al secondo conflitto mondiale ma, politicamente, furono il preludio alla Grande Guerra perché se da un lato una Bulgaria irredentista voleva recuperare dai serbi la Macedonia, dai greci Tessalonica e l’intera Tracia, dai rumeni la Dobrugia meridionale, dall’altra quegli stessi popoli, pur non amandosi, erano costretti da alleanze alla difesa di quel nuovo status quo.
Quei colpi di pistola esplosi a Sarajevo il 28 giugno 1914 dallo studente serbo Gavrilo Princip si inserivano perfettamente nell’evoluzione di quel movimento jugoslavo al quale le potenze occidentali non avevano affatto prestato attenzione.
Con la conversione al cristianesimo, avvenuta nel IX secolo, i popoli slavi del sud (bulgari, serbi, croati e sloveni) si erano separati fra loro aderendo i primi due alla chiesa di Bisanzio e gli altri alla chiesa di Roma. Altro elemento di differenziazione era che nel Medioevo bulgari e serbi avevano formato regni o imperi indipendenti in grado di tenere testa all’impero bizantino mentre gli sloveni non avevano costituito mai uno stato e dai tempi di Carlo Magno erano sottomessi al Sacro Romano Impero prima dei Carolingi, poi degli Ottoni e infine degli Asburgo. I croati invece, dopo due secoli di regno autonomo, dal 1102 erano stati sottoposti alla corona di Santo Stefano e avevano condiviso per otto secoli la sorte degli ungheresi.
Il risultato di tutto ciò fu che bulgari e serbi conobbero quattro - cinque secoli di dominazione ottomana mentre croati e sloveni vissero nell’orbita di Budapest e di Vienna con tutte le caratteristiche religiose e culturali di questi due diversissimi mondi.
Restava la comunione linguistica che però, nel tempo, si era diversificata al punto di fare dello sloveno una lingua distinta, mentre serbi e croati, nel corso del XIX secolo, si erano accordati su una lingua comune sia pur con due scritture diverse, la cirillica e la latina.
La presa di coscienza delle identità nazionali, invece, nasce alla fine del XVIII secolo, sotto l’influsso dell’Illuminismo e poi della rivoluzione francese e fu proprio la comunione linguistica che portò all’idea di una comunità di slavi, poi divenuti jugoslavi.
La proditoria annessione, nell’ottobre 1908, della Bosnia-Erzegovina all’impero austro-ungarico esacerbò gli animi dei nazionalisti serbi e, in breve tempo, nacque a Belgrado un’associazione, la Difesa Nazionale, che cominciò a reclutare sia serbi che croati per combattere le truppe austriache. Contemporaneamente si assisteva ad un inasprimento del nazionalismo croato, ma anche alla diffusione di un jugoslavismo in larghe fasce della popolazione croata.
In Serbia, invece, quest’idea incontrava resistenze sempre maggiori. Certamente, Pietro I di Belgrado era in qualche modo diventato il simbolo dell’unione di tutti gli slavi, ma il partito radicale al potere non gli era favorevole e l’esercito gli era apertamente ostile e continuava a volere fortemente una Grande Serbia che avrebbe inglobato, fra gli altri, anche la Bosnia Erzegovina. Nucleo centrale di questa azione era la società segreta Unione o Morte, detta la mano nera, il cui leader era il colonnello Dragutin Dimtrjevic.
Gavrilo Princip era uno di loro.
Il 28 giugno, festa di San Guido e anniversario della disfatta di Ksovo del 1389, il principe ereditario d’Austria-Ungheria, l’arciduca Francesco Ferdinando, ispezionava in Bosnia, insieme alla moglie, la duchessa di Hohenberg, le manovre dell’esercito.
Caddero entrambi sotto i colpi della pistola del giovane serbo.
L’incidente di Sarajevo sfocerà in una guerra europea e poi mondiale e quei pochi colpi di pistola causeranno la morte di circa dieci milioni di persone.
|

