|
L’attività di Magistretti nel campo del design comincia a metà degli anni Quaranta e procede parallelamente a quella di architetto fino alla conclusione della sua carriera. Non è questo un dato puramente biografico, ma possiede un preciso significato perché la cultura del design italiano è tradizionalmente coincisa con quella dell’architettura, almeno fino agli ultimi anni del XX secolo. La maggior parte dei designers di nuova generazione, invece, non proviene dalle facoltà di architettura ma da scuole specifiche, appositamente create per formare professionisti nel campo del design. Non sono i giovani ad aver fatto dell’arredamento Made in Italy una cla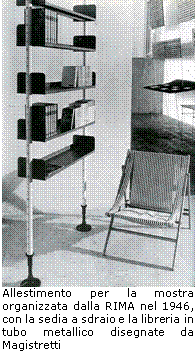 sse di oggetti unici e ricercati in tutto il mondo, amati da ogni esperto arredatore e diffusi nelle riviste di architettura e di moda più sofisticate; è stata invece la retroguardia, la vecchia generazione di architetti-designers, di cui Magistretti rappresenta il tipico esempio, a inaugurare questa felice tradizione, facendo guadagnare e mantenere per diversi decenni all’Italia, e al capoluogo lombardo sopratutto, uno dei primi posti nella classifica dei paesi più alla moda e con il miglior gusto in fatto di design. Ripercorrendo brevemente la carriera di Magistretti designer, personaggio eminente nella scena italiana del secondo dopoguerra, è facile individuare un filo rosso che lega l’esperienza di molti fra i più noti professionisti di quel periodo. Giò Ponti, Achille Castiglioni, Marco Zanuso, Ignazio Gardella, Franco Albini, Joe Colombo, Luigi Caccia Dominioni, sono solo alcuni dei celebri protagonisti di quella che si può certamente considerare l’età aurea del design italiano. sse di oggetti unici e ricercati in tutto il mondo, amati da ogni esperto arredatore e diffusi nelle riviste di architettura e di moda più sofisticate; è stata invece la retroguardia, la vecchia generazione di architetti-designers, di cui Magistretti rappresenta il tipico esempio, a inaugurare questa felice tradizione, facendo guadagnare e mantenere per diversi decenni all’Italia, e al capoluogo lombardo sopratutto, uno dei primi posti nella classifica dei paesi più alla moda e con il miglior gusto in fatto di design. Ripercorrendo brevemente la carriera di Magistretti designer, personaggio eminente nella scena italiana del secondo dopoguerra, è facile individuare un filo rosso che lega l’esperienza di molti fra i più noti professionisti di quel periodo. Giò Ponti, Achille Castiglioni, Marco Zanuso, Ignazio Gardella, Franco Albini, Joe Colombo, Luigi Caccia Dominioni, sono solo alcuni dei celebri protagonisti di quella che si può certamente considerare l’età aurea del design italiano.
Prima di tutto Magistretti aderisce, come molti altri, alla cultura di quel razionalismo revisionista che ha caratterizzato il dibattito sull’architettura dei primi anni Cinquanta. Da questa tendenza deriva l’interesse per la produzione seriale, sentita come fattore necessario e determinante nello studio dei suoi progetti. Il suo approccio, inoltre, si sviluppa nella direzione di un razionalismo stemperato nel rigore dei suoi precetti, con formulazioni dove adesione alla modernità e attenzione alla tradizione delle forme e delle tipologie dell’oggetto domestico trovano un elegante equilibrio. Magistretti è poi convinto che il buon design nasca «a metà strada tra chi progetta e chi fa»; la sua prassi progettuale prevede, infatti, un rapporto di necessaria collaborazione con le aziende. Esaminando il portfolio del designer milanese, si resta colpiti dal fatto che non vi trovano spazio progetti non realizzati o diversi da quelli entrarti in produzione. Questo perché il lavoro di Magistretti, sviluppandosi con la costante collaborazione delle realtà industriali cui spetterà la produzione dei pezzi, esclude l’esistenza di progetti scartati o radicalmente modificati dalle aziende. Non si trovano, inoltre, disegni tecnici definitivi di mano del maestro, secondo il quale è compito del progettista «fornire il concept design ovvero il senso profondo di uso e immagine di un progetto, avvalendosi, nella realizzazione, della raffinata capacità del produttore. […]. Questo è per me design e viene espresso dallo sketching». Il progettista ha quindi il compito di fornire un’idea, il concept, non di elaborare soluzioni tecniche definitive. Lo schizzo di progetto è il vero strumento concettuale di Magistretti. Emerge inoltre una continuità nel suo atteggiamento progettuale: ciò non significa che egli non sia attento all’evoluzione dei gusti, dei co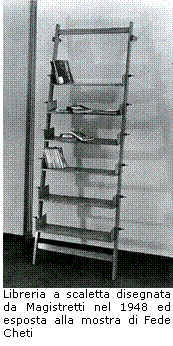 mportamenti sociali e delle ricerche tecniche; al contrario, è innegabile la sua capacità di proporre soluzioni geniali legate alle caratteristiche dei nuovi materiali, alle diverse esigenze degli utenti, ai rinnovati contesti del dibattito culturale. La vera questione è che, nel suo percorso, non si possono rintracciare sostanziali cambiamenti teorici. I dati culturali, tecnici e comportamentali, diversi di fase in fase, sono sempre adoperati come materiale del progetto, che non diventa mai rappresentazione o esaltazione di un singolo fattore. mportamenti sociali e delle ricerche tecniche; al contrario, è innegabile la sua capacità di proporre soluzioni geniali legate alle caratteristiche dei nuovi materiali, alle diverse esigenze degli utenti, ai rinnovati contesti del dibattito culturale. La vera questione è che, nel suo percorso, non si possono rintracciare sostanziali cambiamenti teorici. I dati culturali, tecnici e comportamentali, diversi di fase in fase, sono sempre adoperati come materiale del progetto, che non diventa mai rappresentazione o esaltazione di un singolo fattore.
Dal 1946, a pochi mesi dalla fine della guerra, le due principali riviste del settore, Stile guidata da Pontie Domus da Rogers, sono impegnate nella mobilitazione della cultura architettonica verso il tema della ricostruzione. I primi oggetti disegnati da Magistretti, in collaborazione con Paolo Chessa, sono pubblicati nel numero di Domus del febbraio 1946. Si riferiscono alla trasformazione in abitazione autonoma, per una coppia di giovani sposi, della zona servizi di un appartamento composto da dodici locali. Tre soluzioni sono proposte in quelle pagine, ciascuna con il relativo preventivo di costi, dal più economico al più dispendioso. Per l’occasione i due architetti disegnano anche alcuni mobili: un tavolo ampliabile in tubo metallico, verniciato di nero e di rosso fuoco, e un singolare “porta mensola”, fatto da una sagoma triangolare in tubo metallico bianco, estraibile dal letto in funzione di comodino.
In questo clima, dove la cultura dell’abitare è chiamata a misurarsi con l’impellenza della ricostruzione, hanno luogo alcune iniziative particolarmente significative. Sempre nel 1946 Magistretti partecipa alla mostra della RIMA (Riunione Italiana per le Mostre di Arredamento), che prevede un’esposizione sul tema dell’arredamento popolare, organizzata nel palazzo della storica Triennale di Milano. Tra gli oggetti presentati in questo contesto, quelli firmati da Magistretti sono una libreria con ripiani spostabili lungo due montanti in tubo metallico vincolati a pressione al pavimento e al soffitto, e una semplice sedia a sdraio in legno, redesign ingentilito nelle proporzioni di un modello tradizionale. Nel 1948 ha luogo una mostra organizzata da Fede Cheti, celebre azienda milanese specializzata nella creazione di tessuti per l’arredamento, cui Magistretti partecipa con dei piccoli tavolini di legno sovrapponibili per formare un fantasioso mobile a ripiani, e una singolare libreria, che è in realtà una scaletta da poggiare alla parete. Nei progetti di questi anni è dunque riscontrabile una diffusa adesione al razionalismo, ma il designer aggiunge l’interessante valore estetico della tradizione artigianale, anonima, non viziata da “stilismi”. Il suo esperimento consiste nel rielaborare semplici oggetti d’uso comune, donando loro una funzione inedita. Decontestualizzando mobili e utensili tradizionali, Magistretti reinventa la pratica duchampiana del ready-made e regala ai suoi progetti l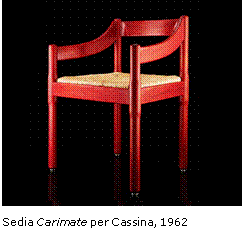 a freschezza e la simpatia di un sorriso. Insieme all’ironia, in questi oggetti si può leggere una dichiarazione di quasi ostentata modestia, la sicura scelta di sobrietà e semplicità che contraddistinguerà sempre il suo stile. a freschezza e la simpatia di un sorriso. Insieme all’ironia, in questi oggetti si può leggere una dichiarazione di quasi ostentata modestia, la sicura scelta di sobrietà e semplicità che contraddistinguerà sempre il suo stile.
Nel decennio successivo Magistretti lavora poco come designer. È, infatti, del tutto assorbito nell’attività di architetto e non ha molto tempo da dedicare al design che, tra le altre cose, non si autofinanzia. In questi anni il suo studio riceve innumerevoli richieste per la realizzazione di abitazioni private di lusso dalle più facoltose personalità italiane, che mettono a disposizione del progettista ingenti somme di denaro per la realizzazione di queste prestigiose dimore. Nonostante ciò, Azucena, una piccola azienda fondata nel 1949 dagli architetti Caccia Dominioni e Gardella, sceglie di produrre i tavolini impilabili che Magistretti aveva presentato l’anno precedente alla Mostra di Fede Cheti. Questo progetto riceve una segnalazione durante la prima edizione del Compasso d’Oro che si svolge nel 1954 anno in cui, inoltre, Magistretti organizza insieme a Caccia Dominioni, Gardella ed altri la Mostra dello standard per la X edizione della Triennale. Nel 1956 fa invece parte del comitato organizzatore che raccoglie le adesioni, cura lo statuto e realizza il primo evento ufficiale dell’ADI, Associazione per il Disegno Industriale. Infine, nel 1960, è scelto come membro della Giunta che cura la XII edizione della Triennale dove sono esposti oggetti disegnati da Castiglioni, Zanuso, Tobia Scarpa e dallo stesso Magistretti.
Alla fine degli anni Cinquanta matura in Italia una situazione nuova, che richiede professionisti in grado di tradurre l’elaborazione teorica e le sperimentazioni degli anni precedenti in risposte concrete. Con il boom economico prende avvio uno sviluppo che modifica profondamente gli assetti socio-economici del paese di pari passo all’industrializzazione, all’urbanesimo, all’aumento del reddito medio, al miglioramento del tenore di vita e all’espansione dei consumi. Il panorama quotidiano degli italiani cambia con la motorizzazione di massa e con la diffusione dei cinema di quartiere e della televisione. Conseguentemente muta la casa con la sua organizzazione domestica: dal bagno alla cucina, ogni ambiente deve essere aggiornato per fare spazio ai nuovi elettrodomestici e all’arredamento moderno (per fare un esempio, l’uso della doccia permette di lavarsi più velocemente, utilizzando meno acqua ed è meno ingombrante). Inoltre, il design d’arredamento è sempre più studiato in modo da permettere la produzione industriale, riducendo i costi e aumentando notevolmente i guadagni rispetto alle manifatture artigianali. Questo avviene grazie all’impegno di alcune piccole e medie imprese, articolate in distretti sul territorio italiano e guidate da imprenditori al passo con i tempi. Questi intuiscono immediatamente l’opportunità degli alti guadagni che comporterebbe la diffusione di un mercato reale per il mobile moderno, prodotto con i macchinari in serie più o meno numerose. Specialmente nelle zone che gravitano intorno alla Milano delle Triennali, del grattacielo Pirelli, della Facoltà di architettura, questi imprenditori entrano in rapporto con gli architetti-designers che, oltre ad occuparsi della fase progettuale, assumono il ruolo di consulenti, un po’ esperti di marketing e un po’ art directors. Si instaura così un particolare rapporto tra il progettista e gli operai interni alla fabbrica i quali, sebbene possiedano una preparazione tecnica adeguata allo sviluppo delle nuove tipologie di arredamento, custodiscono ancora il rapporto con la tradizione artigianale, memoria dell’apprendistato svolto nei sofisticati laboratori di falegnameria e carpenteria metallica dell’anteguerra. Un altro aspetto della questione sul design italiano, riguarda la straordinaria capacità dell’industria e dei progettisti di promuovere il mobile moderno. La diffusione avviene attraverso una serie di iniziative articolate in una massiccia attività di comunicazione, che comprende le cerimonie per il conferimento dei più alti riconoscimenti nel settore (il Compasso d’Oro), l’organizzazione e la cura delle manifestazioni più importanti come il Salone Internazionale del Mobile e le mostre alla Triennale, il coordinamento nella direzione delle riviste e il ruolo espositivo dei negozi. Dall’incontro dei quattro aspetti di cui si è parlato (modernizzazione del paese, trasformazione in senso industriale nella produzione dei pezzi, ruolo degli architetti-designer e della comunicazione) prende avvio lo sviluppo del design italiano. per fare spazio ai nuovi elettrodomestici e all’arredamento moderno (per fare un esempio, l’uso della doccia permette di lavarsi più velocemente, utilizzando meno acqua ed è meno ingombrante). Inoltre, il design d’arredamento è sempre più studiato in modo da permettere la produzione industriale, riducendo i costi e aumentando notevolmente i guadagni rispetto alle manifatture artigianali. Questo avviene grazie all’impegno di alcune piccole e medie imprese, articolate in distretti sul territorio italiano e guidate da imprenditori al passo con i tempi. Questi intuiscono immediatamente l’opportunità degli alti guadagni che comporterebbe la diffusione di un mercato reale per il mobile moderno, prodotto con i macchinari in serie più o meno numerose. Specialmente nelle zone che gravitano intorno alla Milano delle Triennali, del grattacielo Pirelli, della Facoltà di architettura, questi imprenditori entrano in rapporto con gli architetti-designers che, oltre ad occuparsi della fase progettuale, assumono il ruolo di consulenti, un po’ esperti di marketing e un po’ art directors. Si instaura così un particolare rapporto tra il progettista e gli operai interni alla fabbrica i quali, sebbene possiedano una preparazione tecnica adeguata allo sviluppo delle nuove tipologie di arredamento, custodiscono ancora il rapporto con la tradizione artigianale, memoria dell’apprendistato svolto nei sofisticati laboratori di falegnameria e carpenteria metallica dell’anteguerra. Un altro aspetto della questione sul design italiano, riguarda la straordinaria capacità dell’industria e dei progettisti di promuovere il mobile moderno. La diffusione avviene attraverso una serie di iniziative articolate in una massiccia attività di comunicazione, che comprende le cerimonie per il conferimento dei più alti riconoscimenti nel settore (il Compasso d’Oro), l’organizzazione e la cura delle manifestazioni più importanti come il Salone Internazionale del Mobile e le mostre alla Triennale, il coordinamento nella direzione delle riviste e il ruolo espositivo dei negozi. Dall’incontro dei quattro aspetti di cui si è parlato (modernizzazione del paese, trasformazione in senso industriale nella produzione dei pezzi, ruolo degli architetti-designer e della comunicazione) prende avvio lo sviluppo del design italiano.
Nel 1959 Magistretti progetta la Club House di Carimate. Per questo complesso egli organizza anche l’arredamento, disegnando una seduta che deve essere prodotta in molti esemplari per il ristoran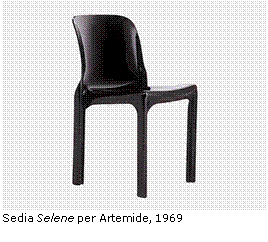 te interno al circolo: è la Carimate, di legno tornito con sedile in paglia. Nel sobrio redesign di una sedia paesana tradizionale è forse possibile avvertire anche l’influenza di un certo gusto scandinavo, che nell’Italia di quegli anni ha molta fortuna. La Carimate, però, è attualizzata con una vivace tintura all’anilina rossa che ne fa slittare l’immagine nella direzione di una nuova modernità. Nel 1960 Magistretti incontra Cesare Cassina, uno dei più dinamici tra gli imprenditori della Brianza. Nel 1962, con la messa in produzione della Carimate per Cassina, ha inizio un lungo periodo di collaborazione tra il designer e l’azienda. te interno al circolo: è la Carimate, di legno tornito con sedile in paglia. Nel sobrio redesign di una sedia paesana tradizionale è forse possibile avvertire anche l’influenza di un certo gusto scandinavo, che nell’Italia di quegli anni ha molta fortuna. La Carimate, però, è attualizzata con una vivace tintura all’anilina rossa che ne fa slittare l’immagine nella direzione di una nuova modernità. Nel 1960 Magistretti incontra Cesare Cassina, uno dei più dinamici tra gli imprenditori della Brianza. Nel 1962, con la messa in produzione della Carimate per Cassina, ha inizio un lungo periodo di collaborazione tra il designer e l’azienda.
Negli stessi anni Magistretti comincia ad affrontare il tema della plastica. Questo materiale, all’epoca, appare molto innovativo, uno di quelli che, come il poliuretano e i truciolati, renderanno possibile la produzione industriale dell’arredamento italiano. Con il progetto Demetrio (1966), in resina stampata e rinforzata, il designer riprende la tipologia dei tavolini sovrapponibili di legno studiata per Azucena. Nel 1969 invece, progetta una sedia stampata in un unico pezzo di resina rinforzata, la Selene. In questo caso, Magistretti non è interessato alla definizione di una forma plastica, una scultura utile anche per sedersi, come fa Verner Panton, ma intende disegnare un oggetto riconoscibile e tipologicamente familiare. In quegli anni Marco Zanuso e Joe Colombo disegnano due sedie di plastica molto interessanti: entrambe hanno le gambe sfilabili, molto corpose per garantire momenti d’inerzia adeguati nelle zone maggiormente sollecitate. Magistretti, invece, risolve il problema “per forma”, configurando le gambe secondo una sezione ad S. Si tratta dello sviluppo di una soluzione già adottata in precedenza, nel 1966, per le gambe del tavolo in plastica Stadio e in una lampada da terra, Chimera, dove rende autoportante una lastra di metacrilato co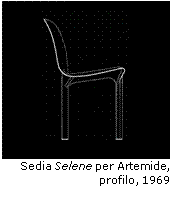 n una forma serpentina. Nel caso di Selene, il risultato è impeccabile: la sedia possiede un’eleganza disinvolta, ha gambe sottili ed è monoblocco, nella piena correttezza d’uso del materiale impiegato. Com’è solito fare, Magistretti esalta il ruolo del tecnico, in questo caso il modellista della fabbrica che ha prodotto la sedia, dicendo: «L’ho fatta con il modellista. Si vede che non è disegnabile. Per disegnarla avrei dovuto fare almeno cento sezioni. Ma c’era questo modellista sublime, andavo da lui, gli parlavo... e il progetto prendeva forma esattamente come l’avevo immaginato!». Negli stessi termini parla anche delle poltroncine di plastica Gaudì e Vicario, del 1970, dove la gamba rimane la stessa, la soluzione per i braccioli è ottenuta forando la scocca e i punti critici sono risolti mediante ispessimenti del materiale. n una forma serpentina. Nel caso di Selene, il risultato è impeccabile: la sedia possiede un’eleganza disinvolta, ha gambe sottili ed è monoblocco, nella piena correttezza d’uso del materiale impiegato. Com’è solito fare, Magistretti esalta il ruolo del tecnico, in questo caso il modellista della fabbrica che ha prodotto la sedia, dicendo: «L’ho fatta con il modellista. Si vede che non è disegnabile. Per disegnarla avrei dovuto fare almeno cento sezioni. Ma c’era questo modellista sublime, andavo da lui, gli parlavo... e il progetto prendeva forma esattamente come l’avevo immaginato!». Negli stessi termini parla anche delle poltroncine di plastica Gaudì e Vicario, del 1970, dove la gamba rimane la stessa, la soluzione per i braccioli è ottenuta forando la scocca e i punti critici sono risolti mediante ispessimenti del materiale.
Nel 1973 nasce uno tra i progetti più famosi del design italiano, la sedia Maralunga. L’innovazione del poggiatesta reclinabile sullo schienale, che non risulta esibita ma rimane nascosta nella configurazione complessiva, trasforma un modello dalla fisionomia consueta assecondando i rinnovati comportamenti, in particolare quelli legati ai nuovi riti televisivi. La versatilità costituisce il punto di forza anche in Veranda, che da poltrona può diventare chaise longue regolabile grazie al sedile-poggiagambe e allo schienale-poggiatesta. In una versione ulteriore ha persino una base ruotante che permette di disporsi in curva per facilitare la conversazione. La poltrona Sinbad, invece, nasce da un concept molto diverso. Il design è qui risolto con un gesto quasi casuale, come q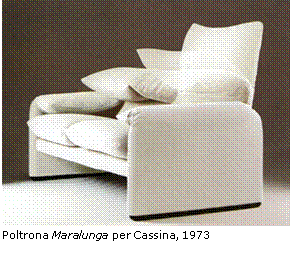 uello di gettare una morbida coperta sopra una poltrona per renderla più calda e accogliente. La sovrapposizione sulla struttura imbottita di un rivestimento dal bordo colorato, simile alle coperte da cavallo usate in Inghilterra, sembra giocare sul prolifico rapporto tra moda e design. Distacco autoironico e gusto per i dettagli raffinati fanno di questo progetto un’idea che si traduce senza sforzo apparente nel mobile, quasi come un gesto elegante. Dall’analisi di questo primo gruppo di progetti emergono tre caratteristiche fondamentali nel lavoro di Magistretti: l’importanza dell’innovazione, nei materiali come nelle risposte ai nuovi comportamenti sociali, ma insieme il rispetto delle tipologie consolidate dall’uso, nel rifiuto della forma fine a se stessa; infine l’uso attento, ma non ostentato né ideologicamente esibito, della tecnica. uello di gettare una morbida coperta sopra una poltrona per renderla più calda e accogliente. La sovrapposizione sulla struttura imbottita di un rivestimento dal bordo colorato, simile alle coperte da cavallo usate in Inghilterra, sembra giocare sul prolifico rapporto tra moda e design. Distacco autoironico e gusto per i dettagli raffinati fanno di questo progetto un’idea che si traduce senza sforzo apparente nel mobile, quasi come un gesto elegante. Dall’analisi di questo primo gruppo di progetti emergono tre caratteristiche fondamentali nel lavoro di Magistretti: l’importanza dell’innovazione, nei materiali come nelle risposte ai nuovi comportamenti sociali, ma insieme il rispetto delle tipologie consolidate dall’uso, nel rifiuto della forma fine a se stessa; infine l’uso attento, ma non ostentato né ideologicamente esibito, della tecnica.
Passando ad un'altra classe di oggetti, è doveroso iniziare parlando di uno tra i più celebri e fortunati progetti di Magistretti, la lampada Atollo, che entra in produzione per O-Luce nel 1977 valendo al maestro il secondo Compasso d’Oro della sua carriera (del primo si parlerà più avanti, mentre il terzo arriverà nel 1979, premiando in ritardo la genialità di Maralunga). Questo pezzo è ormai diventato un classico, a tal punto da essere riprodotto nel calendario che il MOMA ha realizzato per il proprio cinquan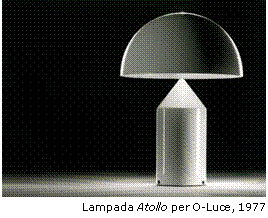 tenario, presentato come uno degli oggetti più rappresentativi delle sue collezioni, non solo di design. Atollo è una lampada da tavolo, interpretazione dell’abat-jour,operata tenendo conto del materiale usato, l’alluminio verniciato. La composizione formale è molto semplice: una calotta sferica con un sostegno cilindrico che diventa conico nella parte superiore. La calotta sembra quasi staccata dal basamento, cui è collegata da un elemento molto sottile, ottenendo un effetto luminoso molto suggestivo poiché, illuminata, sembra galleggiare a mezz’aria. A proposito del gioco luminoso di questa lampada Magistretti dice: «è bello perché ci sono tre luci diverse: il nero, sopra, dove non riceve mai la luce, il bianco all’interno del riflettore e sul cono, e il grigio sul cilindro della base dove la luce arriva sempre parallela come sfiorandolo». La lampada ha superfici esterne levigatissime e le sue forme sono assolutamente armoniose, mai disturbate da elementi sovrapposti. Questo livello di rifinitura ha comportato un vero tour de force per l’industria che l’ha realizzata, con la messa a punto di un involucro per il fissaggio del portalampade e di un sistema per il sostegno della calotta del tutto invisibili. La comp tenario, presentato come uno degli oggetti più rappresentativi delle sue collezioni, non solo di design. Atollo è una lampada da tavolo, interpretazione dell’abat-jour,operata tenendo conto del materiale usato, l’alluminio verniciato. La composizione formale è molto semplice: una calotta sferica con un sostegno cilindrico che diventa conico nella parte superiore. La calotta sembra quasi staccata dal basamento, cui è collegata da un elemento molto sottile, ottenendo un effetto luminoso molto suggestivo poiché, illuminata, sembra galleggiare a mezz’aria. A proposito del gioco luminoso di questa lampada Magistretti dice: «è bello perché ci sono tre luci diverse: il nero, sopra, dove non riceve mai la luce, il bianco all’interno del riflettore e sul cono, e il grigio sul cilindro della base dove la luce arriva sempre parallela come sfiorandolo». La lampada ha superfici esterne levigatissime e le sue forme sono assolutamente armoniose, mai disturbate da elementi sovrapposti. Questo livello di rifinitura ha comportato un vero tour de force per l’industria che l’ha realizzata, con la messa a punto di un involucro per il fissaggio del portalampade e di un sistema per il sostegno della calotta del tutto invisibili. La comp lessità tecnica di Atollo appare completamente nascosta nel risultato finale. Magistretti, infatti, adopera gli espedienti meccanici senza farne uso manifesto, riassorbendoli nel progetto con disinvoltura e distacco. Spesso, nelle sue lampade, compare il concept del gioco di luci. Ad esempio Eclisse, Compasso d’Oro nel 1965, permette di regolare il flusso di luce con la semplice rotazione di due semisfere coassiali; in Nemea (1979) il rapporto tra lo schermo e la base è capovolto e il grande piatto orizzontale si trova, così, investito dalla luce direzionata verso il basso da una piccola calotta di porcellana. Quasi sempre, Magistretti risolve la varietà dei casi nei suoi oggetti luminosi con una struttura formale data dalla composizione di forme geometriche primarie: dalle due semicalotte sferiche concentriche della Mania (1963) all’assemblaggio di tre semisfere in Eclisse, ai due coni capovolti di Pascal (1979). Successivamente, invece, sembra tendere verso una semplificazione formale ulteriore poiché dalle composizioni di volumi passa alle forme geometriche piane, riducendo gli oggetti al nitore di un segno grafico. Nella già citata Nemea, la base perfettamente circolare regge, mediante un sottile montante, la cupoletta in porcellana; in Kuta, del 1978, è lo schermo a forma di cerchio verticale che diventa dominante, mentre il sostegno si riduce ad una linea, e la cupoletta, questa volta, si fa base. Questa ricerca di leggerezza e semplificazione torna in vari progetti degli anni Ottanta, come la sedia Simi (1984), dove un’unica linea curva sorregge la lieve conchiglia in plastica del sedile, o la poltrona Veranda il cui profilo, quando è aperta, disegna una traccia grafica nello spazio. L’amore per le forme geometriche pure si esprime anche nel fatto che i particolari, i giunti, gli attacchi, sono sempre sottaciuti, ridotti al minimo, nascosti e mai adoperati o esaltati in funzione espressiva. Le comp lessità tecnica di Atollo appare completamente nascosta nel risultato finale. Magistretti, infatti, adopera gli espedienti meccanici senza farne uso manifesto, riassorbendoli nel progetto con disinvoltura e distacco. Spesso, nelle sue lampade, compare il concept del gioco di luci. Ad esempio Eclisse, Compasso d’Oro nel 1965, permette di regolare il flusso di luce con la semplice rotazione di due semisfere coassiali; in Nemea (1979) il rapporto tra lo schermo e la base è capovolto e il grande piatto orizzontale si trova, così, investito dalla luce direzionata verso il basso da una piccola calotta di porcellana. Quasi sempre, Magistretti risolve la varietà dei casi nei suoi oggetti luminosi con una struttura formale data dalla composizione di forme geometriche primarie: dalle due semicalotte sferiche concentriche della Mania (1963) all’assemblaggio di tre semisfere in Eclisse, ai due coni capovolti di Pascal (1979). Successivamente, invece, sembra tendere verso una semplificazione formale ulteriore poiché dalle composizioni di volumi passa alle forme geometriche piane, riducendo gli oggetti al nitore di un segno grafico. Nella già citata Nemea, la base perfettamente circolare regge, mediante un sottile montante, la cupoletta in porcellana; in Kuta, del 1978, è lo schermo a forma di cerchio verticale che diventa dominante, mentre il sostegno si riduce ad una linea, e la cupoletta, questa volta, si fa base. Questa ricerca di leggerezza e semplificazione torna in vari progetti degli anni Ottanta, come la sedia Simi (1984), dove un’unica linea curva sorregge la lieve conchiglia in plastica del sedile, o la poltrona Veranda il cui profilo, quando è aperta, disegna una traccia grafica nello spazio. L’amore per le forme geometriche pure si esprime anche nel fatto che i particolari, i giunti, gli attacchi, sono sempre sottaciuti, ridotti al minimo, nascosti e mai adoperati o esaltati in funzione espressiva. Le comp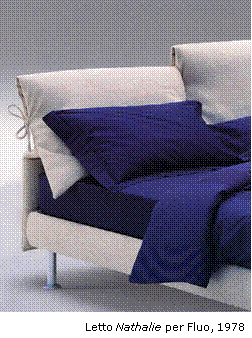 osizioni di volumi, spesso sezionati e giustapposti, tipiche di molte lampade di Magistretti, appartengono a quel filone di ricerca che connette geometria e produzione industriale, dal De Stijl olandese al Costruttivismo russo, dal Bauhaus a certa scultura astratta. osizioni di volumi, spesso sezionati e giustapposti, tipiche di molte lampade di Magistretti, appartengono a quel filone di ricerca che connette geometria e produzione industriale, dal De Stijl olandese al Costruttivismo russo, dal Bauhaus a certa scultura astratta.
Nel 1978 Magistretti progetta per una nuova azienda, Flou, un letto fortunatissimo, che sarà seguito da molti altri: Nathalie, che nella testata riprende il disegno di Maralunga, inaugurando la moda dei letti tutti imbottiti. Qualche anno dopo Ermellino avrà anche la testata e il bracciolo modificabili. Questi letti si caratterizzano per l’assenza di ogni elemento strutturale visibile. L’immagine regala una sensazione di assoluta morbidezza, cui contribuisce l’uso del piumone e dei cuscini reclinabili poggiaschiena.
Negli ultimi vent’anni della sua carriera, dal 1986 al 2006, anno in cui è scomparso, Magistretti intraprende una collaborazione molto prolifica con l’azienda De Padova. Dedicandosi nuovamente all’osservazione degli oggetti della tradizione anonima, crea una collezione di complementi d’arredo che esprimono in modo completo quell’idea di un abitare elegantemente sobrio e disinvolto. Questa fase progettuale inizia con Vindun (1986), un tavolino dove il piano si sposta in altezza grazie ad un sistema a vite, ripreso dai tradizionali tavoli da lavoro (vindun, in milanese, significa grossa vite), e con Marocca (1987), altro redesign ingentilito di un’antica sedia da osteria veneta. Alla stessa filosofia progettuale si lega la ricerca sulle potenzialità degli oggetti pieghevoli, da cui nasce una serie di mobili per Campeggi, disegnati negli anni Novanta. La collaborazione con D e Padova, inoltre, porta alla creazione di due sedie molto interessanti. Silver (1989) è la rielaborazione in alluminio di una sedia di legno, la 811 disegnata nel 1925 da Breuer per Thonet; alcuni anni dopo, la segue Maui (1996), in cui viene riproposto, con gambe d’acciaio e monoscocca di plastica, lo schema che Arne Jacobsen aveva risolto con il multistrato. In entrambi in casi, Magistretti compie la rilettura di due progetti di rilievo tipologico pressoché definitivo, modificati sulla base delle possibilità offerte dalle alte prestazioni dei nuovi materiali. Nella Maui, ad esempio, la scocca è rinforzata senza nervature o costolature, mediante una doppia curva di piegatura all’attacco tra schienale e sedile, soluzione che in compensato sarebbe irrealizzabile. Un altro gruppo di tre sedute, realizzate tra il 1994 e il 1999, merita di essere citato per la grande precisione formale e tecnologica della loro fattura, che ne fa, secondo la simpatica definizione di Gillo Dorfles, dei “personaggi d’arredo” nitidi ed essenziali: sono la Vico (1994), la Vicoduo (1997) e la Vicosolo (1999). La prima è di betulla stampata ad elementi separati, legati alla struttura d’acciaio da giunti speciali che consentono, con la loro flessibilità, estrema libertà di movimento; la seconda è una monoscocca di betulla che poggia su una piastra di alluminio in cui si inseriscono le gambe metalliche; la terza è un’ulteriore versione del disegno iniziale, ridotta all’essenziale per diminuire i costi e rendere così possibile la diffusione dell’oggetto ad aree diverse da quella domestica. e Padova, inoltre, porta alla creazione di due sedie molto interessanti. Silver (1989) è la rielaborazione in alluminio di una sedia di legno, la 811 disegnata nel 1925 da Breuer per Thonet; alcuni anni dopo, la segue Maui (1996), in cui viene riproposto, con gambe d’acciaio e monoscocca di plastica, lo schema che Arne Jacobsen aveva risolto con il multistrato. In entrambi in casi, Magistretti compie la rilettura di due progetti di rilievo tipologico pressoché definitivo, modificati sulla base delle possibilità offerte dalle alte prestazioni dei nuovi materiali. Nella Maui, ad esempio, la scocca è rinforzata senza nervature o costolature, mediante una doppia curva di piegatura all’attacco tra schienale e sedile, soluzione che in compensato sarebbe irrealizzabile. Un altro gruppo di tre sedute, realizzate tra il 1994 e il 1999, merita di essere citato per la grande precisione formale e tecnologica della loro fattura, che ne fa, secondo la simpatica definizione di Gillo Dorfles, dei “personaggi d’arredo” nitidi ed essenziali: sono la Vico (1994), la Vicoduo (1997) e la Vicosolo (1999). La prima è di betulla stampata ad elementi separati, legati alla struttura d’acciaio da giunti speciali che consentono, con la loro flessibilità, estrema libertà di movimento; la seconda è una monoscocca di betulla che poggia su una piastra di alluminio in cui si inseriscono le gambe metalliche; la terza è un’ulteriore versione del disegno iniziale, ridotta all’essenziale per diminuire i costi e rendere così possibile la diffusione dell’oggetto ad aree diverse da quella domestica.
 Nel 1996 il Compasso d’Oro per la carriera è assegnato a Magistretti, riconoscimento quasi ovvio per un’attività che, come la sua, è stata tanto lunga e importante nella storia del design italiano. Il grande talento di questo professionista è sempre stato quello di esibire modestamente i suoi valori etici ed estetici. La sobrietà, l’orrore per l’ostentazione e per l’aggressività formale, il rifiuto della ridondanza vista come perdita di contenuto nella comunicazione del pezzo, la tecnica dell’ understatement per evitare chiavi interpretative inutilmente ambiziose, l’eleganza come disinvoltura e naturalezza, la padronanza delle tecniche e l’apertura all’innovazione senza che ciò comporti l’abbandono della tradizione: queste sono le principali caratteristiche del design firmato Magistretti. |


 Nel 1996 il Compasso d’Oro per la carriera è assegnato a Magistretti, riconoscimento quasi ovvio per un’attività che, come la sua, è stata tanto lunga e importante nella storia del design italiano. Il grande talento di questo professionista è sempre stato quello di esibire modestamente i suoi valori etici ed estetici. La sobrietà, l’orrore per l’ostentazione e per l’aggressività formale, il rifiuto della ridondanza vista come perdita di contenuto nella comunicazione del pezzo, la tecnica dell’understatement per evitare chiavi interpretative inutilmente ambiziose, l’eleganza come disinvoltura e naturalezza, la padronanza delle tecniche e l’apertura all’innovazione senza che ciò comporti l’abbandono della tradizione: queste sono le principali caratteristiche del design firmato Magistretti.
Nel 1996 il Compasso d’Oro per la carriera è assegnato a Magistretti, riconoscimento quasi ovvio per un’attività che, come la sua, è stata tanto lunga e importante nella storia del design italiano. Il grande talento di questo professionista è sempre stato quello di esibire modestamente i suoi valori etici ed estetici. La sobrietà, l’orrore per l’ostentazione e per l’aggressività formale, il rifiuto della ridondanza vista come perdita di contenuto nella comunicazione del pezzo, la tecnica dell’understatement per evitare chiavi interpretative inutilmente ambiziose, l’eleganza come disinvoltura e naturalezza, la padronanza delle tecniche e l’apertura all’innovazione senza che ciò comporti l’abbandono della tradizione: queste sono le principali caratteristiche del design firmato Magistretti.