| |
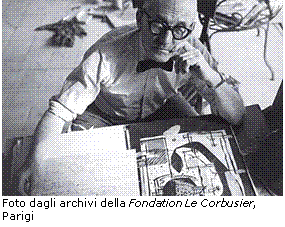 Charles-Eduard Jeanneret-Gris nasce a La Chaux-de-Fonds nel 1887. Adotterà il celebre nome d’arte Le Corbusier sul finire del 1919 quando, con A. Ozenfant, prepara l’uscita della rivista “L’Esprit Nouveau”. Gli scritti dei due amici su tale pubblicazione sono così numerosi che per non essere accusati di monotonia decidono di assumere due pseudonimi. Ozenfant sceglie il nome della madre (Saugnier); Jeanneret adotta invece un patronimico che aveva sentito usare in famiglia: Le Corbusier. Utilizzerà questo nome per gli articoli di architettura e urbanistica, mentre continuerà a firmarsi Jeanneret in molti dei suoi quadri e negli scritti di pittura, scultura e poesia. Charles-Eduard Jeanneret-Gris nasce a La Chaux-de-Fonds nel 1887. Adotterà il celebre nome d’arte Le Corbusier sul finire del 1919 quando, con A. Ozenfant, prepara l’uscita della rivista “L’Esprit Nouveau”. Gli scritti dei due amici su tale pubblicazione sono così numerosi che per non essere accusati di monotonia decidono di assumere due pseudonimi. Ozenfant sceglie il nome della madre (Saugnier); Jeanneret adotta invece un patronimico che aveva sentito usare in famiglia: Le Corbusier. Utilizzerà questo nome per gli articoli di architettura e urbanistica, mentre continuerà a firmarsi Jeanneret in molti dei suoi quadri e negli scritti di pittura, scultura e poesia.
Mentre in Europa è scoppiata la prima guerra mondiale, Le Corbusier sembra averne una visione distaccata ed utilitaristica: i progetti di case Domino nascono dalla conoscenza delle distruzioni causate dalla guerra nelle Fiandre. Il nome scelto per questo sistema di prefabbricati industriali deriva dal gioco omonimo, alla cui tesserina rettangolare assomiglia la singola struttura a sei pilastri e due piani (corrispondente ad un alloggio), da giustapporre in modo assolutamente libero, ma preferenzialmente ortogonale (proprio come le tessere del gioco), alle altre cellule, in modo da formare filari, doppi filari, quinte, slarghi e piazze.
Da questo progetto derivano i disegni per gli Immeubles-villas del ’21 che, insieme ai Redents del ’25, lo porteranno a concepire la sua versione della Città-giardino verticale, tema prediletto dal socialismo utopistico e sviluppato in infinite varianti dagli architetti del primo dopoguerra.
Con il passare degli anni l’atteggiamento di Le Corbusier nei confronti della restaurazione post-bellica cambia radicalmente. Le ragioni di questa maturazione etica sono numerose: i lunghi viaggi in Europa, in Medio Oriente e nelle Americh e gli hanno lasciato un bagaglio di esperienze ed emozioni che presto diventeranno fonte d’ispirazione indispensabile per il grande architetto; inoltre egli ha maturato una profonda delusione nei confronti della società borghese e delle autorità politiche che continuano a disprezzare il suo lavoro o, semplicemente, a non capirlo. e gli hanno lasciato un bagaglio di esperienze ed emozioni che presto diventeranno fonte d’ispirazione indispensabile per il grande architetto; inoltre egli ha maturato una profonda delusione nei confronti della società borghese e delle autorità politiche che continuano a disprezzare il suo lavoro o, semplicemente, a non capirlo.
Durante e dopo il secondo conflitto mondiale Le Corbusier è consapevole della situazione di emergenza in cui migliaia di persone vivono a causa della guerra. Sono necessarie case di emergenza per sinistrati, profughi, lavoratori delle industrie belliche. Sistemazioni provvisorie, ma pur sempre dignitose.
La tecnocrazia progettuale dalla quale, dopo la prima guerra mondiale, era nata l’idea per le case Domino, lascia il posto ad un modus operandi di carattere diametralmente opposto.
La sua proposta per la seconda guerra mondiale è lucidamente fisiocratica:«servitevi della terra comune, in grosse zolle con le quali erigere spessi muri maestri, sopra i quali appoggerà una copertura a falde inclinate, fatta con legnami di bosco e infine delle zolle erbose che fanno ruscellare la pioggia…» suggerisce alla gente.
Le Corbusier ha scoperto questo metodo costruttivo in America latina, ma durante il viaggio con il cugino Pierre Jeanneret a Ghardaia (Algeria) e al Qued Mzab (regione della Chebka in Marocco) l’iniziale curiosità si è trasformata in vivo interesse. Negli anni successivi, infatti, l’architetto studierà in maniera molto approfondita l’architettura e l’ingegneria della tradizione islamica.
Da queste idee nascerà il progetto per le case Murondins che sono realizzabili con una procedura costruttiva molto semplificata (poiché la costruzione non ambisce ad invecchiare), adattata al clima europeo (copertura inclinata in zolle erbose, anziché piana e in terra ammassata e cementata) e rappresentano la risposta dell’architetto al problema degli sfollati durante l’emergenza bellica.
E’ sua convinzione, inoltre, che anche costruzioni pubbliche, specie in anni difficili, possano essere fatte in estrema economia: come certe moschee, certe scuole islamiche e certi alberghi da lui visitati nel Maghreb e ad Algeri.
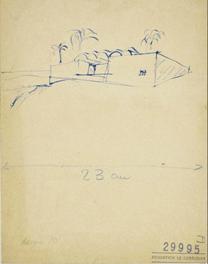 Interessante il concetto della “migrazione” interna alla casa, per evitare i vani più caldi nelle ore di sole, frutto dell’osservazione delle abitudini domestiche musulmane: secondo questo principio progetterà molti dei suoi edifici negli anni successivi. La “Corte agricola” nei pressi di Cherchell, una settantina di km ad ovest di Algeri, ne è un esempio. Il progetto è del 1942, un momento in cui ancora non esiste mano d’opera specializzata il loco e i materiali costruttivi sono quasi introvabili. Perciò l’edificio è progettato in modo che possa essere costruito dagli indigeni usando pietre locali per pilastri, muri e tramezzi. I solai sono in legno e il tetto a volta ribassata è in mattoni vuoti prodotti dagli indigeni stessi. Inoltre questo tipo di architettura spontanea riesce ad integrarsi perfettamente nel paesaggio, rispondendo all’ampiezza della scogliera, alla solitudine del luogo e alla grandezza degli orizzonti. Interessante il concetto della “migrazione” interna alla casa, per evitare i vani più caldi nelle ore di sole, frutto dell’osservazione delle abitudini domestiche musulmane: secondo questo principio progetterà molti dei suoi edifici negli anni successivi. La “Corte agricola” nei pressi di Cherchell, una settantina di km ad ovest di Algeri, ne è un esempio. Il progetto è del 1942, un momento in cui ancora non esiste mano d’opera specializzata il loco e i materiali costruttivi sono quasi introvabili. Perciò l’edificio è progettato in modo che possa essere costruito dagli indigeni usando pietre locali per pilastri, muri e tramezzi. I solai sono in legno e il tetto a volta ribassata è in mattoni vuoti prodotti dagli indigeni stessi. Inoltre questo tipo di architettura spontanea riesce ad integrarsi perfettamente nel paesaggio, rispondendo all’ampiezza della scogliera, alla solitudine del luogo e alla grandezza degli orizzonti.
Al regionalismo passivo e retrogrado Le Corbusier oppone, in un’estrema povertà di mezzi, gli splendori possibili dell’architettura.
Bisogna ricordare il binomio case Murondins + Fattoria Cherchell e la comune influenza islamica perché quasi sempre, dal 1940 in avanti, Le Corbusier prediligerà schemi semplici, pareti portanti in muratura o pietrame, materiali grezzi, volte ad arco molto ribassato realizzate “alla catalana”.
Seguendo questi principi l’architetto progetta una città a La Saint-Baume (una regione montuosa a nord-est di Marsiglia) nel ‘48 e le abitazioni Roq e Rob a Cap Martin nel ’49. Tra il 1950 e il 1955 disegna i progetti per altri due edifici con le medesime caratteristiche: la casa del Prof. Fueter sul lago di Costanza e quella di Madame Sarabhaiad Ahmedabad. Infine il celebre progetto per le case Jaoul a Neuilly-sur-Seine sviluppa e completa questa filosofia progettuale.
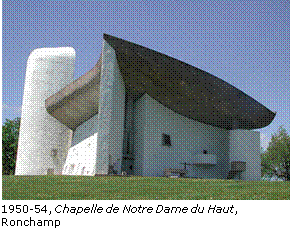 Naturalmente va posto in questo elenco anche uno dei capolavori assoluti del grande architetto francese: la Chapelle de Notre Dame du Haut a Ronchamp. Naturalmente va posto in questo elenco anche uno dei capolavori assoluti del grande architetto francese: la Chapelle de Notre Dame du Haut a Ronchamp.
Le Corbusier non è forse del tutto consapevole di quanto la conoscenza della tradizione islamica abbia influenzato la progettazione di queste strutture; oppure, più verosimilmente, non è disposto ad ammetterlo per non avere guai (lui che è già protestante) con la committenza cattolica, specie nel caso di Ronchamp. L’incarico gli viene affidato da Padre Coutrier che lo accompagna a visitare il sito dove si trovava la preesistente cappella neogotica, distrutta dalla guerra, e dove sorgerà la nuova costruzione.
Giunto per la prima volta sulla cima della collina di Ronchamp nel maggio 1950 l’architetto osserva che il programma è piuttosto spartano poiché ci sono parecchie difficoltà economiche. Egli accetta comunque la commissione, anche perché il luogo gli è particolarmente caro: Ronchamp si affaccia sulla valle della Soane e sulle familiari montagne del Giura svizzero (dove si trova la contea di Neuchatel in cui sorge La Chaux-de-Fonds, paese natale del Maestro) e, nelle giornate serene, il panorama spazia da queste ultime fino alle bianche vette delle Alpi.
 I canons a lumière che illuminano le tre cappellette degli altari minori di Notre Dame du Haut sono, oltre che una rielaborazione delle prese d’aria e di luce di tante case musulmane, anche una chiara citazione classica (basti pensare all’oculo del Phanteon romano) e una rivisitazione delle prese d’aria sui ponti delle navi, modello studiato approfonditamente durante i lunghi viaggi oltreoceano. I canons a lumière che illuminano le tre cappellette degli altari minori di Notre Dame du Haut sono, oltre che una rielaborazione delle prese d’aria e di luce di tante case musulmane, anche una chiara citazione classica (basti pensare all’oculo del Phanteon romano) e una rivisitazione delle prese d’aria sui ponti delle navi, modello studiato approfonditamente durante i lunghi viaggi oltreoceano.
Tutto l’andamento curvilineo del perimetro della chiesa, le curve contrapposte, agganciate, incernierate l’una sull’altra sono una libera interpretazione delle misteriose regole di ambientamento delle costruzioni spontanee, oltre che la diretta conseguenza delle pareti libere degli anni venti.
L’importanza fondamentale del progetto per Notre Dame Du Haut risiede nel fatto che esso segna la tappa iniziale nella lunga ricerca per trovare la perfetta alchimia di ombra-luce-spazio all’interno degli edifici, che Le Corbusier chiamerà acustica architettonica e che pochi anni dopo porterà alla stupefacente realizzazione del Padiglione Philips.
 Quando Louis Kalff, architetto, ingegnere e direttore artistico della Philips, si reca da Le Corbusier per chiedergli di progettare un padiglione, precisa subito che il suo intento non è di esporre in maniera commerciale la produzione dell’azienda, bensì presentare uno spettacolo basato su effetti acustici e illuminotecnici inediti, una dimostrazione tesa a magnificare gli splendori del progresso e a rivelare dove questo potrà arrivare nel futuro. Quando Louis Kalff, architetto, ingegnere e direttore artistico della Philips, si reca da Le Corbusier per chiedergli di progettare un padiglione, precisa subito che il suo intento non è di esporre in maniera commerciale la produzione dell’azienda, bensì presentare uno spettacolo basato su effetti acustici e illuminotecnici inediti, una dimostrazione tesa a magnificare gli splendori del progresso e a rivelare dove questo potrà arrivare nel futuro.
Le Corbusier risponde prontamente: «Non vi farò un padiglione, vi farò un Poème Electronique e la bottiglia che lo conterrà!». Subito pensa alla collaborazione di due grandi artisti all’avanguardia: Edgar Varèse per la musica e Jannis Xenakis per il design e gli aspetti tecnici.
Edgard Varèse, noto musicista parigino, compositore di melodie dai toni molto singolari, è considerato father of Electronic Music.
Jannis Xenakis, compositore e architetto di origini greche ma francese d’adozione, ha avvicinato la progettazione architettonica alla composizione musicale e visiva tramite una sintesi scientifica, creando un vocabolario comune e coniando termini tecnici e concetti assolutamente innovativi.
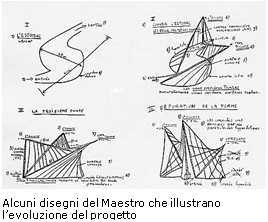 Le superfici del Padiglione seguono curve paraboliche e iperboliche regolate da funzioni algebriche, creando un ambiente molto suggestivo dalle forme morbide e quasi antropomorfe. Richiamano inoltre i motivi grafici della partitura per metastasis, composta nel 1954 da Xenakis. Uno scheletro di acciaio e cemento sostiene tutta la struttura: la tensione dei cavi d’acciaio agganciati a supporti in cemento e rivestiti da pannelli prefabbricati, consente di creare un tipo di volume assolutamente nuovo, una “scatola magica” dai contorni sinuosi. Le superfici del Padiglione seguono curve paraboliche e iperboliche regolate da funzioni algebriche, creando un ambiente molto suggestivo dalle forme morbide e quasi antropomorfe. Richiamano inoltre i motivi grafici della partitura per metastasis, composta nel 1954 da Xenakis. Uno scheletro di acciaio e cemento sostiene tutta la struttura: la tensione dei cavi d’acciaio agganciati a supporti in cemento e rivestiti da pannelli prefabbricati, consente di creare un tipo di volume assolutamente nuovo, una “scatola magica” dai contorni sinuosi.
Il Poème électronique rappresentato all’interno del Padiglione è uno spettacolo molto originale e altrettanto sconcertante, pensato come un'opera per orchestra dove la melodia è suonata da strumenti virtuali rappresentati dalle luci, dagli altoparlanti, dalle immagini proiettate sulle superfici irregolari, dalle ombre e dalle espressioni degli spettatori, in una sostanziale identificazione dello spazio con il suono.
La struttura è progettata per accogliere seicento spettatori ogni otto minuti, precisamente 480 secondi, il tempo fissato per ogni rappresentazione. Uno spazio continuo in cui non esiste alcuna distinzione fra pareti e soffitto. Al contrario: la forma a “stomaco” della pianta è strettamente legata allo sviluppo dell’involucro. Le Corbusier ha seguito un’idea molto precisa nella progettazione del Padiglione, ideando un concetto spaziale che per analogia rimanda alla digestione: la gente entra, vede, sente, digerisce, esce e metabolizza. Quello che conta é passare attraverso una situazione nuova.
 L’esperienza sensoriale è completata dal suono organizzato composto da Varèse e diffuso mediante 350 altoparlanti articolati in strade sonore che conducono lo spettatore attraverso l’ambiente sbalorditivo creato dalle superfici architettoniche di Xenakis. Così le pareti interne, sulle quali corrono righe parallele poste orizzontalmente, assumono l'identità di spartiti. L’esperienza sensoriale è completata dal suono organizzato composto da Varèse e diffuso mediante 350 altoparlanti articolati in strade sonore che conducono lo spettatore attraverso l’ambiente sbalorditivo creato dalle superfici architettoniche di Xenakis. Così le pareti interne, sulle quali corrono righe parallele poste orizzontalmente, assumono l'identità di spartiti.
Il Poème Electronique vuole mettere in scena, in mezzo a un tumulto angosciante, la storia della civiltà partita alla conquista dei tempi moderni: il brano di Varèse, della durata di otto minuti, sintetizza il lungo cammino dell'umanità e termina in un'apoteosi ottimistica aperta verso un mondo di gioia e di armonia a venire.
L’obiettivo di Le Corbusier è di creare un vero e proprio “gioco” elettronico e sincronico in cui il volume della struttura, il movimento creato dai visitatori e il suono dell’età moderna diano vita all’ambiente in modo sbalorditivo e innovativo.
Il risultato è stupefacente. Il Padiglione Philips è una struttura futuristica e rivoluzionaria che aderisce allo spettacolo come un vestito ad un corpo: la prima Opera Multimediale dell’era elettronica.
Malauguratamente, una sintesi così visionaria di idee innovative risulterà troppo in anticipo rispetto ai tempi, ed un analogo paradigma non solo non sarà più ripetuto, ma neppure nuovamente tentato: il Padiglione, nonostante l’incredibile numero di spettatori (due milioni), fu distrutto pochi mesi dopo la sua inaugurazione, alla fine dell’Esposizione.
È il 1958 e sono giunti gli ultimi anni di vita del maestro.
Egli è occupato a dirigere i lavori per la costruzione del convento di Santa Maria della Tourette, nei pressi di Lione, iniziato nel 1953 quando padre Couturier (che tre anni prima gli aveva fatto ottenere l’incarico per Notre Dame du Haut) lo aveva raggiunto a Parigi proponendogli di realizzare questo nuovo, prestigioso progetto.
Per comprendere a fondo la natura di questo edificio monastico e i motivi che hanno ispirato Le Corbusier in fase progettuale, bisogna tornare agli anni di gioventù del maestro, quando egli faceva apprendistato in studi di celebri architetti (come L’Eplattenier e Behrens) e viaggiava per l’Europa giungendo in Italia dove, nei pressi di Firenze, era rimasto incantato dalla Certosa d’Ema che tornerà a visitare e studiare più volte.
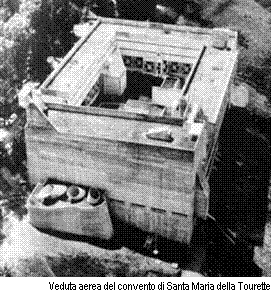 La Certosa, fondata nel 1341 da Niccolò Acciaiuoli, sorge alla sommità di un monte, in prossimità di un piccolo dirupo. La pianta quadrata dell’edificio è caratterizzata da un ampio chiostro che ne delimita i quattro lati, su due dei quali si allineano le celle dei monaci: alloggi ad L su due piani, affacciati su di un piccolo giardino interno. Tali alloggi ricordano molto da vicino le cellule degli Immeubles-villas, progettati dal maestro tra il 1922 e il 1925, poiché le dimensioni del vano (12x16m circa) sono praticamente le stesse. La Certosa, fondata nel 1341 da Niccolò Acciaiuoli, sorge alla sommità di un monte, in prossimità di un piccolo dirupo. La pianta quadrata dell’edificio è caratterizzata da un ampio chiostro che ne delimita i quattro lati, su due dei quali si allineano le celle dei monaci: alloggi ad L su due piani, affacciati su di un piccolo giardino interno. Tali alloggi ricordano molto da vicino le cellule degli Immeubles-villas, progettati dal maestro tra il 1922 e il 1925, poiché le dimensioni del vano (12x16m circa) sono praticamente le stesse.
Nel convento della Tourette è palese il richiamo all’antico tipo della certosa con corte centrale e pianta quadrata, sebbene Le Corbusier inserisca elementi esotici e stravolti chiarori. Inoltre il terreno è in pendenza e non è regolato da terrazzamenti. Ne consegue che quattro corpi del complesso sono innalzati su pilotis (come la celeberrima Villa Savoye) e che alcuni spazi, come ad esempio la cappella, sono gradonati. Infine la tradizionale pianta quadrata è sostituita da una partizione cruciforme che crea un’immagine invertita: i portici non si trovano più a racchiudere il vuoto del cortile ma occupano essi stessi la parte centrale, separandosi dalle entità del convento.
Le logge delle celle, su doppia altezza, formano il coronamento dell’edificio e fungono da frangisole. I livelli inferiori sono chiusi dal pan de verre ondulatoire, un sistema a pannelli di calcestruzzo e vetri in cui di tanto in tanto sono introdotti gli aeratori, fessure verticali chiuse da ante girevoli e da una zanzariera.
Le celle dei monaci, equipaggiate con un lavabo e un arredamento spartano, rappresentano la sintesi degli studi sull’existenz minimum iniziate negli anni ’20 e sviluppate attraverso l’osservazione delle cabine dei vagoni letto e delle navi.
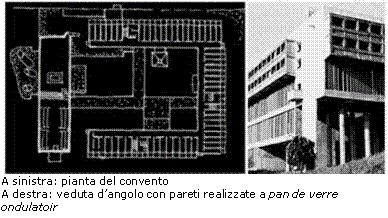 Il lato che dà a sud comprende il refettorio e la biblioteca, aperti verso l’interno tramite un muro che gioca sull’alternanza di rettangoli pieni e vetrati, chiamato in seguito muro “Mondrian”. Il lato che dà a sud comprende il refettorio e la biblioteca, aperti verso l’interno tramite un muro che gioca sull’alternanza di rettangoli pieni e vetrati, chiamato in seguito muro “Mondrian”.
Il parallelepipedo della chiesa sorge come un elemento autonomo, leggermente separato dalla U dell’edificio principale. L’oscurità che regna all’interno dell’aula, rafforzata dalla pietra nera con cui è realizzato il pavimento sotto l’altare, è ad un tratto smorzata da due fessure verticali che si aprono nelle parerti est ed ovest. In una cripta adiacente al volume dell’aula principale si trovano i sette altari sui quali i domenicani celebrano simultaneamente la messa (secondo un rito proprio dell’ordine che è stato soppresso dopo il concilio Vaticano II). Questi sono circondati da un muro sinuoso e illuminati dai canons a lumière che proiettano colori vivaci. La sagrestia, situata dall’altro lato della navata, come a formare un transetto, è illuminata da sette mitragliatrici di luce trasversali dal ritmo più irregolare.
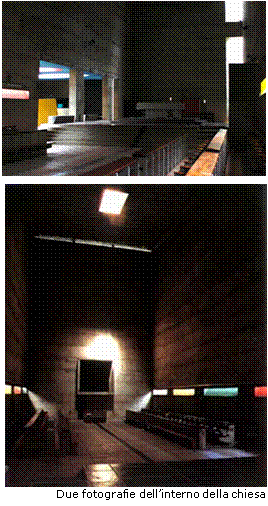 In prossimità dell’entrata, segnata da tre cilindri, una piccola piramide è sovrastata da un’altra più grande di cemento. I due passaggi porticati si incrociano in un atrium coperto da un tetto spiovente, proponendo una passeggiata architettonica stupefacente. I muri di questi portici sono scanditi da vetrate ondulate i cui serramenti, con misure fissate dal Modulor, proiettano a terra ombre lineari e mutevoli. In prossimità dell’entrata, segnata da tre cilindri, una piccola piramide è sovrastata da un’altra più grande di cemento. I due passaggi porticati si incrociano in un atrium coperto da un tetto spiovente, proponendo una passeggiata architettonica stupefacente. I muri di questi portici sono scanditi da vetrate ondulate i cui serramenti, con misure fissate dal Modulor, proiettano a terra ombre lineari e mutevoli.
Le Corbusier inizia la progettazione di questo maestoso edificio nel 1953, il cantiere si apre nell’agosto del 1956 e il primo di luglio 1959 i religiosi prendono possesso del luogo.
Nel 1963 arriva la proposta dell’Amministrazione provinciale veneziana: realizzare un ospedale da 1200 posti letto. Le Corbusier stende un primo progetto nel 1964 e, nei primi mesi del ’65 disegna il progetto definitivo dove stabilisce l’organizzazione orizzontale dell’intero edificio, preoccupandosi di non alterare la silhouette storica di Venezia.
Le stanze di degenza presentano una soluzione molto innovativa. Ogni paziente ha una cella singola senza aperture di finestre: durante il giorno la luce entra negli ambienti attraverso aperture superiori, che regolano anche l’effetto del sole. Un particolare sistema di ventilazione (ispirato alle soluzioni islamiche) permette di regolare la luce e la temperatura in modo da offrire al paziente una sensazione di confortevole isolamento.
È l’estate del 1965 e verso gli ultimi giorni di luglio Le Corbusier parte per la villeggiatura sul Mediterraneo, nel suo Cabanon di Roquebrune.
“…Il 27 agosto 1965, quest’uomo di settantotto anni, che ormai risente dei rigori dell’età, conclude alla svelta il discorso sull’Ospedale di Venezia: «Sapete, io sono un vecchio citrullo, ma ho ancora in testa progetti per lo meno per cent’anni. Arrivederci a presto, dunque!». In pieno sole Le Corbusier s’infila per lo stretto sentiero che scende verso il mare tra le rocce di Cap Martin, per fare il suo bagno malgrado il formale divieto del medico. Quando dei pescatori riporteranno sulla spiaggia il corpo, senza neanche sapere che appartenesse al grande Maestro, si constaterà che è morto di una crisi cardiaca…” (Stanislaus von Moos, Le Corbusier l’architecte et son mythe, Horizon de France, 1971).
“Un uomo come Le Corbusier non può morire; il 27 agosto 1965 è soltanto cambiato il modo di pensare a lui” (Ernesto N. Rogers, Le Corbusier tra noi, Pesce d’Oro, Milano 1966).
Il ciclo biologico di Le Corbusier si è compiuto: egli è tornato al Mediterraneo, alla terra da cui provenivano i suoi avi.
|

